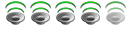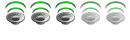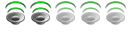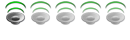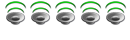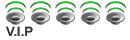Ho pensato di aprire un grosso contenitore dove si possano mettere le recensioni dei libri che abbiamo letto e che vorremmo consigliare a tutti, anche letture non inerenti l'infame, non si deve pensare sempre e solo a quello, ogni tanto è meglio svagarsi un po'!!! Wink
Comincio io.
Il primo libro non è il massimo dell'allegria, ma per me è stato spunto di tante riflessioni, e spero che un giorno sia anche base su cui impostare alcuni "atteggiamenti" lavorativi.
Marco Venturino: "Cosa sognano i pesci rossi"

Un viaggio di conoscenza di cosa è un reparto di terapia intensiva, visto dalla parte del medico e del paziente. Una storia attuale, che ci riporta a pensare alla sofferenza umana, al mondo ospedaliero, alle scelte terapeutiche, al conflitto che a volte i medici devono affrontare, l'umanizzazione del paziente, l'umanità e a volte la pietà. L'autore è un anestesista milanese che vive quotidianamente questa realtà e che ha saputo, e aggiungerei ha avuto la forza, di raccontare al "mondo esterno" cosa si vive in un reparto così delicato. Questa realtà io la vivevo tutti i giorni, era difficile e cercavo sempre di lasciarmela alle spalle appena uscivo dal lavoro. Leggere questo libro mi ha fatto tornare in mente tante storie che ho vissuto, tanti volti, tante riflessioni che ho fatto, tanti pazienti e tanti colloqui coi parenti. E' un libro duro, difficile, che fa riflettere seriamente, a volte si vorrebbe interrompere la lettura, certe descrizioni sono molto forti.
E' il racconto di un uomo ricoverato in terapia intensiva dopo un intervento chirurgico andato "non troppo bene" per un brutto tumore polmonare. Le sue condizioni cliniche sono disperate e le possibilità di uscirne sono nulle. Ma lui è ancora vivo, pensa e soprattutto si rende conto di dove è e cosa gli sta succedendo e che sta morendo lentamente. Ed è questo che è terribile. Nella sua vita di malato incontra un dottore, e le loro vite a questo punto sono intrecciate e per qualche tempo proseguiranno appaiate. Il paziente è il pesce rosso, incapace di esprimersi, può solo pensare, ma dipende in tutto e per tutto dagli altri, capace di provare dolore ma incapace di dirlo, capace di voler contatto umano, una persona che non vorrebbe essere commiserata, che non vorrebbe essere chiamato col numero del suo letto, che vorrebbe gridare "Io ci sono ancora, non sono solo un corpo attaccato alle macchine! Qualcuno venga qui e cerchi di dialogare un po', non lasciatemi solo con i miei pensieri"
Il libro viene narrato sia dal paziente che dal medico, e si sviluppa tutto intorno all'evoluzione del declino fisico del paziente. Ci sarà un interazione tra i due, solidarietà, voglia di vivere, attraverso emozioni, piccole gioie e grandi dolori.
Una storia terribile, dolorosa, molto forte, che però fa riflettere su cosa sia il senso della vita e fino a che punto sia corretto proseguire le cure, su cosa sia meglio per il medico e su cosa sia meglio per il paziente. Su come un paziente possa vivere un'esperienza così drammatica, i suoi pensieri, le sue sensazioni, i suoi bisogni. Su come anche una sola parola di un infermiera possa ferire o far gioire.
Questo libro io lo consiglio come un ottimo spunto di riflessione su vita e morte, sull'accanimento terapeutico e anche sull'eutanasia; mette in luce quello che pensa l'uomo-medico e quello che pensa (si, pensa) l'uomo-paziente; ci si trova davanti a una realtà che per molti è solo qui, per altri è vita quotidiana, per altri ancora è stata o sarà una parte della vita, purtroppo.
Qui c'è una recensione fatta da professionisti...meglio della mia!! Embarassed Laughing Laughing :
http://www.bol.it/libri/scheda/ea978880454533.html
Dall'incontro con Marco Venturino al Festival della Scienza di Genova:
A dispetto del titolo un po' surreale Cosa sognano i pesci rossi è un'opera prima di grande rilevanza, capace di smuovere nel profondo l'animo del lettore perché riesce a conciliare la riflessione "alta" sulla vita e la morte, con la descrizione della più spiccia e talvolta degradante quotidianità. A prendere alternativamente la parola nel romanzo di Marco Venturino, direttore della divisione di Terapia intensiva all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, sono due coetanei quarantacinquenni. Il primo è Pierluigi Tunesi, amministratore delegato di una grande azienda che dopo un'operazione malriuscita viene ricoverato d'urgenza nel reparto di Terapia intensiva. Immobilizzato e reso muto da una tracheotomia, Tunesi si trova davanti il disincantato medico Luca Gaboardi. Sono loro, rispettivamente, "il pesce rosso", chiuso nel suo acquario di silenzio, e la "faccia verde" che si china su di lui per aiutarlo nella misura in cui il suo essere medico e uomo gli permette. Lo sconvolgente romanzo di Venturino dà per la prima volta parola all'umanità dei medici, alla loro impotenza di fronte al dolore altrui, alla difficoltà di lavorare in un luogo che, come lo stesso autore dichiara al pubblico intervenuto alla sua conferenza, "è una trincea". Venturino ha fotografato la realtà così com'è, senza filtro alcuno, descrivendo con profonda pietas e grande efficacia tanto la sofferenza della malattia, quanto la muta perseveranza di chi, medico o malato, crede e lotta per la vita. Il suo è un romanzo che, sfidando il tabù della morte, risveglia l'attenzione nei confronti del dolore, dando così luogo ad una necessaria presa di coscienza. In occasione del Festival della Scienza, abbiamo incontrato Marco Venturino per parlare un po' del suo libro e della sua figura di medico-scrittore:
"Le mie mani che manipolano corpi, violano recessi, inseriscono sonde e cateteri nelle integrità altrui hanno ben poco a che fare con la vita. La vita è un'altra cosa. Semmai io agisco sulla sopravvivenza, ma neanche questo è poi tanto vero." Il medico non ha più a che fare con la vita?
Non è esattamente così, ma in determinate situazioni limite di lotta per la sopravvivenza ci si dimentica un po' che cosa è la vita e si fanno quindi manovre offensive nei riguardi del paziente, manovre che magari non hanno neanche tanto senso. O peggio ancora hanno senso ma vengono fatte male e allora ci si dimentica della persona per limitarsi a perseguire unicamente la malattia.
A questo proposito nel romanzo si parla di accanimento terapeutico, ma anche della sterile ambizione medica che, se qualcosa va male, abbandona il paziente a se stesso…
Non dimentichiamo che il libro è un romanzo che racconta una storia e non un trattato. Al suo interno troviamo personaggi positivi e negativi, ma bisogna ricordarsi che sono esseri umani. L'ambizione nella medicina e nella chirurgia può essere una qualità negativa, può sfociare in accanimento terapeutico ma non è di per sé accanimento terapeutico. Questo significa non considerare l'uomo in tutte le sue dimensioni, ma trattarlo un po' come un oggetto per la propria carriera Non è tanto una critica alla medicina, è una constatazione di eventi che possono accadere perché alcuni medici possono avere queste caratteristiche. Perché i medici sono esseri umani.
Luca Gaboardi, il medico protagonista, si dibatte tra questi temi, ne soffre, ma non assume una posizione precisa, ne prende atto senza combattere. Dice spesso "Ma come faccio a sopportarmi?" Perché?
Non è facile ribellarsi alle cose che non vanno perché le situazioni sono più complicate di quello che sembrano. Prendiamo la figura del "chirurgo senza scrupoli" presente nel romanzo: sarebbe semplicistico definirlo un personaggio completamente negativo, perché, in realtà, è un bravissimo chirurgo e allora diventa molto difficile ribellarsi alla sua componente negativa. Non tutti poi hanno il coraggio e la forza di opporsi, l'atteggiamento di Gaboardi è l'emblema del venire a compromessi, che è purtroppo una regola che coinvolge tutti noi qualunque sia l'attività che svolgiamo.
Parliamo un po' di comunicazione: quella del medico nei confronti del paziente e quella invece nei confronti del parente. Pierluigi Tunesi vuole la verità, lo grida dentro se stesso, lo dice con gli occhi e con le poche forze che gli rimangono. Nessuno però gli parla onestamente delle sue condizioni è pietas o vigliaccheria?
Come sempre è un misto di entrambi gli aspetti. Talvolta si vuole non essere duri o non si ha il coraggio dire a una persona che deve morire. Bisogna avere maturato una consapevolezza di sé e della propria vita molto forte per riuscirci. La realtà è sempre variegata e quindi ci sono situazioni diverse, come nel caso di alcuni pazienti che sono i primi a non volere sapere nulla. Ma tra il medico che non vuole dire e il paziente che non vuole sentire esistono tutta una serie di sfumature, da cui si deduce che quello tra medico e paziente è il rapporto più difficile che ci sia.
Proviamo invece ad analizzare il rapporto tra medico e parente: i familiari dei malati attribuiscono ai medici il ruolo di stregoni, di entità superiori capaci di portare la guarigione, di aggiustare ciò che è rotto. Ma spesso, durante il decorso della malattia, è il parente il primo ad accorgersi che il proprio caro sta peggiorando. E il medico non ascolta. Clara, la moglie del suo protagonista, capisce che il marito sta perdendo il contatto con la realtà, ma nessuno la sta a sentire.
Le dirò di più, per una certa parte dei colleghi il parente è un fastidio per diversi motivi: perché lo vede come il portatore di possibili procedimenti giudiziari e perché il medico si trova a dover svelare la sua ignoranza, confessare di non avere una risposta precisa, cosa che per un medico non è assolutamente tollerabile. In terzo luogo i parenti sono un fastidio perché il medico è un essere umano e in ogni essere umano c'è una grossa componente di pigrizia per cui qualunque cosa prolunghi l'attività diventa una seccatura. Tutto ciò fa sì che il rapporto tra medici e parenti sia molto difficoltoso. Poi bisogna anche considerare che si sono situazioni di familiari assillanti, che non vogliono capire. Anche in questo caso la realtà è molto variegata. Ciò di cui bisogna rendersi conto è che si ha a che fare con un uomo, con i suoi affetti e con la sua speranza e questo spesso tendiamo a dimenticarlo.
Luca Gaboardi, cinico e disincantato, parla a un certo punto di "imbarazzo emozionale". Può chiarire questo punto?
Non è nient'altro che l'inadeguatezza che l'individuo prova nei confronti del dolore dell'uomo.
E' sempre Gaboardi in quell'occasione a rivolgere al suo collega entusiasta e pieno di buone intenzioni una domanda: "Ci siamo spinti troppo avanti e tornare indietro non è più possibile. Ma ha senso tutto questo?"
E' davvero complesso stabilire dove ci si deve fermare. Anche dell'argomento eutanasia se ne parla spesso a sproposito: in tanti anni di lavoro non ho avuto neanche una richiesta di eutanasia, anzi semmai la richiesta è sempre quella di andare oltre, tentare l'intentabile, sia da parte dei pazienti sia da parte delle famiglie. Sapere dove e quando fermarsi è la cosa più difficile perché la medicina va avanti, ma l'uomo continua a rimanere mortale.
Il ritratto è impietoso eppure, per chiunque abbia avuto esperienze del genere, assolutamente realistico: non sarebbe opportuno sostituire al necessario cinismo dei medici quella compassione necessaria ad accompagnare il paziente nel suo percorso?
Assolutamente si. La missione del medico è quella di curare, che significa prendersi cura del paziente nella sua totalità. Guarire invece è un'altra cosa. Avremmo bisogno di uno psicologo fisso a terapia intensiva, non tanto per i pazienti, quanto per gli operatori. E comunque non potrebbe mai sostituire la compassione.